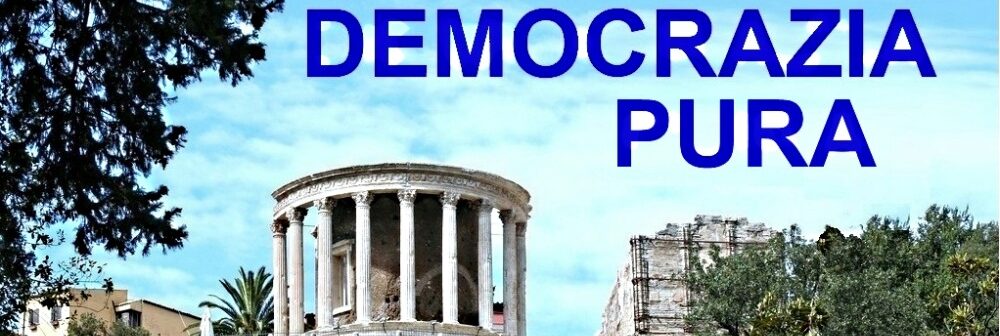Si riporta parzialmente il dibattito che si è svolto sulla pagina di un social network qualche giorno dopo la pubblicazione dell’articolo.
C.R. (22/01/2020). Bellissima analisi! E’ vero: come ci sono traumi che bloccano per sempre lo sviluppo di una personalità, così può avvenire per una comunità, per esempio per un partito, per una città a volte persino per un’intera nazione. Un evento enormemente traumatico e insieme vergognoso, doloroso soltanto a ripensarlo, può chiudere le porte del futuro, imprigionare in un mondo in cui il tempo non scorre più, in cui nulla di nuovo può crescere, in cui si tenderà a ripetere all’infinito un copione ben collaudato, per essere sicuri di non toccare zone dolenti, per non rischiare. Non è facile uscire da queste trappole. Ci vuole molto coraggio, molta creatività. Un caso esemplare fu – credo – quello del Sud Africa, in cui si decise di non punire chi avesse semplicemente pubblicamente confessato crimini commessi durante l’Apartheid. Non dovette esser cosa facile contemplare gente che confessava per ore fatti crudeli, che avevano rovinato la vita di molti, che avevano causato grande dolore e grandi ingiustizie. Ma nell’emergere della verità, molte cose si trasformavano, compresi gli aguzzini, che dopo una tale confessione non avrebbero più potuto essere gli stessi, né compiacersi del male compiuto; per cui si riaprivano le porte del futuro.
C.R. (22/01/2020). Un’ultima considerazione mi viene da fare: purtroppo la storia italiana anche recente è ricca di fatti con caratteristiche simili alla tragedia del 1799 a Napoli. Fatti in cui il dolore si somma alla vergogna per l’impunità, fatti duri da guardare, che non possono essere né disfatti né “superati”. Come il volto orrendo di Medusa, essi pietrificano gli astanti, li imprigionano in un tempo che non passerà più. Io stesso, nella mia breve vita, ne ho visti alcuni: le bombe da piazza Fontana in poi; poi l’assassinio di Aldo Moro, voluto e perpetrato più da alcuni rappresentanti delle istituzioni che dagli stessi rapitori; poi le uccisioni di Falcone e Borsellino; e altri fatti luttuosi che hanno coinvolto un minor numero di persone (Ustica, ecc.). In tutti questi fatti, l’impunità e la non-verità continueranno ad incenerire ogni possibile germoglio di riconciliazione. Sono fatti che si può fingere di ignorare, oppure che si può continuare a ripercorrere: in entrambi i casi essi eserciteranno il loro incantesimo. Le generazioni successive potranno – col tempo – giungere a non conoscerli, ma essi resteranno là, come i ripugnanti delitti dei Sanfedisti per Raffaele La Capria, nato più di un secolo dopo. E sarà impossibile guardarli, senza subirne a propria volta il raggelante sguardo.
C.D.L. (22/01/2020). Analisi al solito impeccabile. Grazie, C. R.. Nella seconda parte vengono descritte le modalità attraverso le quali si manifesta il “fuori dalla storia” o, come poi l’ho definita io, l’ipostoria. Un altro aspetto cui mi vorrei dedicare consiste proprio nell’analisi delle ragioni che bloccano o rallentano la storia di una comunità. Perché l’evento traumatico può assumere sembianze diverse. Penso per esempio all’emigrazione di massa che ha caratterizzato interi territori e che ancora oggi rappresenta un lutto melanconico in qualche maniera paralizzante.
G. D. (22/01/2020). Omaggio molto bello all’arte di un grandissimo scrittore, alla sua intelligenza del mondo, al suo memorabile stile. Aspetto con vivo interesse la seconda parte.
C. R. (22/01/2020). Una cosa è certa: dopo questo post, leggerò “Ferito a morte” di La Capria, che avevo acquistato anni fa per una curiosità poi soverchiata da altre vicende, e che avrebbe seriamente rischiato – non per sua colpa – di non venir letto mai. Lo dico perché, leggendo il post, mi sembra di condividere del La Capria (1) l’amore per la Napoli che era e che sarebbe potuta essere, (2) i sentimenti contrastanti per quello che invece Napoli è (o mi pare sia) e (3) il senso di orrore che provo per tutte le volte in cui le genti dell’Italia scelsero di non essere più libere e più civili.
C.D.L. (22/01/2020). Ai fini del discorso che stiamo facendo è di grandissimo interesse anche L’Armonia perduta, una raccolta di articoli nei quali La Capria teorizza compiutamente i contenuti espressi nel romanzo. E aggiunge anche molto altro.
Fe. I. (22/01/2020). Molto interessante. Colpiscono le parole di La Capria. Si può però correttamente ritenere interrotta la storia di una civiltà cittadina senza presupporre l’esistenza di un genius loci? E’ lecito pensare che i lumi importati dalla Francia avrebbero messo in chiaro l’anima vera della città? Come non pensare che la storia delle comunità non sia altro che un continuo avvicendarsi di poteri, classi, idee, persone che si mischiano si soverchiano e si confondono di continuo in modo tanto complesso da rendere impossibile la sopravvivenza di un carattere costante, utile a classificarle?
C.D.L. (22/01/020. L’eccidio del 1799 decapitò un élite colta che secondo alcuni avrebbe potuto trascinare Napoli (e il Sud) verso la modernità determinando una paralisi proprio nello sviluppo storico che tu dicevi.
Fe. I. (22/01/2020). Sì. Mi lascia solo un po’ perplesso il concetto espresso da La Capria di sorte della città. Sorte interrotta. Come se esistesse un carattere o talento naturale della città da compiersi. Che non si è più compiuto. Non mi convince. Ma comunque la riflessione è molto interessante. Aspetto la seconda parte con curiosità.
G.D. (22/01/2020). Lo sguardo di La Capria rimane quello di uno scrittore e l’idea che la città abbia una sua vocazione è forse più estetica che storico-sociale, più letteraria ma nel senso più alto e magari anche ingenuo dell’aggettivo. Per il resto credo si possa essere d’accordo con l’analisi dello scrittore partenopeo. Cosa è mancato, cosa continua a mancare al meridione d’Italia? Da meridionale sono convinto che la risposta sia proprio una borghesia colta. L’irredimibile subalternità delle genti meridiane si spiega così a mio avviso.
Fe. I. (22/01/2020). Discorso difficile, sfuggente. Il rischio è giudicare tutto secondo parametri di riferimento preconfezionati. Non ho per il resto la preparazione sufficiente per esprimere un parere serio sulla questione. Ma vi ascolto con interesse. E credo che presto leggerò La Capria.
C.D.L. (22/01/2020). Non trovo convincente il discorso di La Capria sulla “napoletanità” e sul dialetto inventati dalla piccola borghesia superstite per tenere a bada il mostro dei lazzaroni. O meglio, ci devo riflettere ancora.
G. A. (23/01/2020). La Capria parla della Napoli vera e della montatura e questo mi ha ricordato,per immagine, come Cristiano ha d’altronde menzionato, il romanzo di Anna Maria Ortese “Il mare non bagna Napoli”, in cui è offerto un quadro realistico, sostenuto da forte impegno politico e sociale, della Napoli più povera e popolare degli anni ’50, quadro che è possibile vedere in tutto il Meridione. La dicotomia fra la ipostoria, la storia sotterranea dei “bassi” napoletani, e la storia che scorre in superficie è espressa qui attraverso il racconto di Eugenia, una bambina in trepidante attesa del suo primo paio di occhiali, che le permetteranno di vedere nitidamente il mondo. Quando li indossa nel cortile della sua casa, ciò che vede è ben diverso da quello che aveva visto nel luccicante negozio del centro di Napoli e che si aspettava fosse ovunque.Le si para di fronte un’umanità misera e tanto cenciosa da farle provare un forte malessere, che è psicologico prima ancora che fisico. Ecco, questo straniamento, la percezione negativa della realtà che si oppone fortemente a quella inizialmente positiva, mette a fuoco il mutamento di prospettiva e la reale percezione del “basso” napoletano, contrapposto alle comode case borghesi. Grazie per aver sottolineato gli aspetti peculiari e contraddittori della napolanità e di aver offerto spunti di riflessione sulla questione meridionale, che emergono dal testo.
Fi.I. (23/01/2020). Due i concetti che mi hanno particolarmente colpito: 1. la presenza, nei luoghi della ipostoria, di dinamiche interne capaci di trasformare, ma non di sterilizzare, i cambiamenti esterni. 2. L’incapacità, da parte di questi luoghi, di metabolizzare “quegli eventi sovrastanti che […] intervengono e si impongono violentemente”. Non ho letto, purtroppo, La Capria. Mi riprometto di farlo quanto prima, perché la sua analisi, quale emerge dal tuo resoconto, mi sembra raffinata e soprattutto specifica. La questione meridionale, di cui ci si continua a interessare dalle più diverse prospettive (storica, letteraria, cinematografica ecc.), mi sembra spesso un grande calderone all’interno del quale vengono confuse situazioni diversissime fra loro. Tornare ad analizzarle una a una, soffermandosi sulle specificità di ciascuna senza lasciarsi sedurre da categorie generali, mi sembra un primo passo essenziale per affrontarle in modo coerente ed efficace. Un ultimo plauso, a te e a chi te l’ ha suggerita, per la scelta di abbinare al post le immagini di Nino Migliori, a parer mio uno dei migliori fotografi italiani e non solo. Un abbraccio.
C. K. (23/01/2020). Penso che due caratteri indolenti figli della buona borghesia patrizia, due anime comode, sognatrici (i protagonisti del romanzo), siano senz’altro uno spicchio veritiero di quella piega “immobile” che per molti aspetti ammanta la “napoletanità”. Ma nel romanzo La Capria parla con grande amore anche di due Napoli, “la vera e la montatura”, stupenda ambiguità sfuggente nella quale si agita ogni sorta di verità sociale, informe, guasta, malata, imprendibile a lume di logica, e spesso negativa. Il concetto di “attesa del miracolo” è verissimo, ma la definizione di “ipostoria” si invalida presto in un evento che solo loro hanno saputo scolpire, unici al mondo. Napoli si è liberata DA SOLA dal nazifascismo, esempio irripetuto. Non è per glorificare un’eccezione, ma per sottolineare come le chimiche della concretezza e del lassismo, mescolandosi, mostrino insieme il brillio e la carenza, la costola rotta e i muscoli pronti, a seconda del caso, del momento. Napoli è troppe cose e nessuna, questo il suo pazzesco e contraddittorio inventario. Ma personalmente, e per quanto valga, leggo in tutto questo una piega per nulla limitata, ma ancor più vasta, ampia, indefinibile e magmatica, che è poi il pozzo della poesia da cui salgono i secchi del romanzo di La Capria. La spigola non viene raggiunta, i destini dei protagonisti franano, ma residua in questo (e da questo) l’esattezza compiuta di una poesia che è quella degli eroi letterari, dei mancati, degli inetti, degli incompresi, per colpa certo loro ma anche dell’intorno che li avvolge. Son quei caratteri che imprimono alla letteratura il vero inchiostro che la abita, e nessun ambiente come Napoli è quadro più giusto per intagliarne ogni sillaba. Il fuori che ammorba e il dentro insonnolito; ma da essi sortisce un romanzo perfetto. Suggerirei, sul lato plebeo, di leggere Rea e la Ortese, è un altra ruga sul volto, ben più tremenda, atroce. L’armonia del resto, volendo massimizzare con faciloneria credo anche giustificata, è sempre perduta, specie di questi tempi. Direi insomma che aveva ragione Croce nella sua definizione: “Un paradiso abitato da diavoli”.
G. D. (23/01/2020). Caro C.K., anche il tuo è uno sguardo letterario e non potrebbe essere altrimenti scorrendoti nelle vene la somma arte della parola poetica. Suggestivo e condivisibile in larga parte il tuo commento. Credo però che l’intuizione sull’ “ipostoria” meriti una diversa attenzione o quantomeno un supplemento di indagine, proprio per la sua capacità di tenere insieme, tentandone una spiegazione, quello che con felice espressione definisci “contraddittorio inventario”. Bello il suggerimento della Ortese e soprattutto del purtroppo dimenticato Rea.
C. K. (23/01/2020). Napoli è un universo, pozzanghera e oro, bestemmia e sangue sciolto. Una di quelle realtà per me irriconducibili a un termine secco o a una condotta o a un unico motivo di fondo. Definire è sempre un diminuire come diceva Saramago, sarei per amarne i limiti e le grazie come in un abbandono d’amore, amaro e sentito al tempo. Per il resto con semplicistica cretineria mi verrebbe da dire che ovunque, di questi tempi,è il trionfo dell’ipostoria. Se però l’iperstoria è guerra e macchina di dominio mi tengo l’ipo come una dolce culla che mi dondoli nel sonno. Un caldo abbraccio di cuore Giovanni…P.S. Il Rea è il Domenico di Ninfa Plebea.
G.D. (23/01/2020). È vero che definire è sempre diminuire e quella di Napoli è una storia ostinatamente irriducibile a qualsivoglia formula definitiva, logica, razionale. Quando penso a Napoli, città che amo, mi viene in mente il capolavoro di Chico Buarque de Hollanda “O que serà”. Non credo che il rapporto tra ipo e iperstoria, almeno nel senso esplicitato da Carlo, stia nei termini di una contrapposizione in cui l’iperstoria sia guerra o macchina di dominio, però ho capito cosa intendi e sono d’accordo. C.D.L. (23/01/2020). Consentitemi di ringraziare ancora G. D. che, con un post molto suggestivo pubblicato sul suo profilo, mi ha spinto a leggere i due libri di La Capria attraverso i quali ho potuto sviluppare ulteriormente il filone dell’”ipostoria” che inseguo da un po’ di tempo. L’associazione con la fotografia di Migliori pure è stata strepitosa. Se nell’articolo i ringraziamenti sono formulati in maniera dimessa è solo per il timore che potesse non essere gradita una citazione più esplicita pubblicata su un blog personale, il mio, sul quale è comparso inizialmente il testo. Credo che seguirò i consigli di Cristiano, amico colto e assolutamente affidabile nei giudizi, perché il mio interesse per Napoli e la sua storia non si è ancora esaurito. E sarò ben lieto di contrarre un ulteriore debito di gratitudine.
ORFEO, LO SCIAMANO (pubblicazione marzo 2019)
CDL (10/11/2017). Un testo di grande ampiezza e di grande profondità intellettuale. Molti gli spunti sulla osmosi tra filosofia greca e religiosità orientale. Un elemento che mi sembra di poter rilevare é la differente struttura religiosa che caratterizza orfismo e pitagorismo. L’orfismo sembra appartenere ad una religiosità primordiale anche per il fatto che la concezione sacrale è una norma istituente e rappresenta il fondamento della società. In questa concezione il destino degli uomini é comune e per questo non può essere accettata alcuna violazione che metterebbe in pericolo l’intera comunità. Nel pitagorismo invece sembra prevalere una religiosità moderna nella quale il personale sacro si separa dal resto della società (da cui il carattere iniziatico) e la responsabilità diventa individuale.
Fe.I. (11/11/2017). L’aspetto che evidenzi è molto complesso secondo me. In realtà sembra si possa affermare che l’aspetto soteriologico distingua l’orfismo dallo sciamanesimo tout court: introduce una teoria generale dell’anima e dei suoi cicli che forse era assente negli ambienti originari centrasiatici. La concezione sciamanica dell’anima imprigionata e antagonista del corpo viene mutuata chissà da chi in Grecia ed elaborata in funzione di una richiesta di giustizia personale. L’opposizione corpo anima diventa un’antonomasia e dà origine ad una filosofia delle contraddizioni (corpo anima, terra cielo, vita morte, caldo freddo, pari dispari…) che forse ha contribuito al sorgere di un nuovo pensiero analitico e di una teorica razionale che tramite Pitagora arriva a Platone e da lì entra pienamente in circolo nella communis opinio. La distinzione tra orfismo e pitagorismo sembra a questo punto tra due stati di avanzamento differenti della medesima concezione di fondo: l’orfismo, più antico, ha un linguaggio narrativo e un’ascendenza popolare; il pitagorismo elabora un sistema di pensiero su quella mitologia, costruisce un linguaggio, crea una scuola, con essa una classe di iniziati analoga a quella misterica
LA STORIA DEI VINCITORI E QUELLA DEI VINTI (commenti: Febbraio 2019; pubblicazione: Febbraio 2019)
MF (2 Febbraio 2019). “La storia la fanno i vincitori” è una frase che indica come in genere gli scritti storici dei vinti tendano a lasciare pochissimi testimoni quando non nessuno. Ciò non solo per un “complotto dei vincitori” teso ad eliminare versioni concorrenti che comunque erano anch’esse tendenzialmente partigiane; ma anche per un – diciamo così – “genuino” disinteresse dei vincenti nei confronti della versione di coloro che hanno perso. Col procedere della prevalenza del vincitore in termini di durata temporale, si riduce anche la resilienza del “perdente” nel continuare a proporre una versione differente ricoperta dalla cappa del silenzioso disinteresse. Poi, come ha notato qualcuno, la riproposta del passato degli sconfitti si presenta spesso come qualcosa di niente affatto “oggettivamente” critico, ma spesso di _opposto_ quando non mitologico. Alle volte la rinarrazione di una sconfitta è quella di vincitori che affermano la propria discendenza dagli sconfitti, addirittura appoggiandosi ai vincitori (Roma fondata da Enea appoggiandosi ad un passo di Omero, ed i tantissimi popoli discesi dai troiani in conseguenza di quel primo esempio). Dunque bisogna anche vedere di _che_ vinti si parla.
CDL (2 Febbraio 2019). Considerazioni condivisibili. Sebbene la tesi di Koselleck sia suggestiva: in teoria un’analisi degli errori che hanno portato alla sconfitta può rappresentare la base per una interpretazione del passato più profonda.
MF (2 Febbraio 2019). Indubbiamente. Tuttavia, a parte casi rarissimi, è difficile trovare nelle opere storiche superstiti dell’antichità, per esempio, casi di “mea culpa” da parte del vincitore. E’ un atteggiamento che ha cominciato a diffondersi in tempi abbastanza recenti in Occidente per tutta una serie di motivi legati ad un retaggio culturale misto, se posso permettermi il paradosso, illuministico-cristiano, di un cristianesimo debole però, perché quello forte è abbastanza feroce (Ambrogio che scrive che i morti pagani sono morti giusti come contrappasso a quelli cristiani: nonostante il “porgi l’altra guancia” e “perdona il tuo nemico” del fondatore). Quando capita, scopriamo una forma di pietà pagana che è quella la quale trova a certe disgrazie la giustificazione del mancato rispetto per le rappresentazioni delle divinità del nemico – l’episodio della Giunone di Veio in Livio è un rovesciamento di questo tema.
POLITICA E PARRESIA (commenti: Settembre 2017; pubblicazione: Febbraio 2016)
Fe.I. (2 Marzo 2017). Nell’articolo Carlo De Luca espone, discute ed analizza il saggio “Discorso e verità nella Grecia antica” di Michel Foucault. Nel suo lavoro Foucault descrive la genesi e l’evoluzione in Grecia del concetto di parresía, dallo Ione di Euripide, alla maiuetica socratica, allo scandalismo di Diogene fino alla verità come costruzione logica nella morale, che tramite lo stoicismo, ne trasporta il senso all’interno dell’universo cristiano. Esistono tre ambiti di efficacia per la pratica della parresia, secondo De Luca: sociale, politico e filosofico. Il primo quando prevale il rapporto personale con gli altri; il secondo, che riguarda il rapporto pubblico con gli altri; il terzo, quando rileva il rapporto del parresiasta con se stesso. Sembra che in epoca moderna sia venuta meno la centralità che il valore della parresia svolgeva invece nel mondo greco. In particolare De Luca suggerisce il venir meno della parresia come valore d’insieme nella sua triplice declinazione socio-politico-filosofica: siamo infatti abituati a sentir predicare verità pubbliche da chi ostenta contraddizioni in privato. Tutto questo con rilevanti implicazioni sul principio della responsabilità politica, dell’accountability e, in fondo, sull’esperibilità di un efficace controllo democratico.
Fi.I. (17 Settembre 2017). Articolo interessantissimo, bisognerebbe riflettere bene sull’adombrata responsabilità circa il declino della democrazia ateniese ascritta proprio alla marginalizzazione della parresia, dovuta forse al prevalere di logiche elettoralistiche o latamente adulatorie nei confronti del potere.
CDL (17 Settembre 2017). Un’altra figura antica legata alla parresia è quella di Cassandra nella quale si possono riconoscere le stigmate dell’intellettuale critico (non organico).
Fe.I. (17 Settembre 2017). Gioco parresiastico per antonomasia è l’invettiva diretta – ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν – della commedia αρχαία. Basti pensare agli attacchi a Cleone, campione dei populares, che Aristofane mette in scena nei Cavalieri.
SCONTRO DI CIVILTA’ O FINE DELLA STORIA? (commenti: Marzo 2017; pubblicazione: Febbraio 2013)
Fi.I. (2 Marzo 2017). Mi sembra che dal dibattito fra post-modernismo e neo-conservatorismo si possano trarre utili indicazioni sul fulcro della questione trattata: se cioè, al giorno d’oggi, permanga ancora uno spazio per concezioni differenti del mondo – culturali, economiche, politiche – o se invece, in accordo con quanto sostenuto da Fukuyama, si debba parlare di “fine della Storia”, ammettere cioè di essere giunti all’ approdo finale di una civiltà umana univoca e unidirezionale nel suo sviluppo. Mi sembra che una prospettiva molto interessante da cui guardare ai segni dei tempi nostri sia fornita dalla teoria del “paradigma”, elaborata dal filosofo T.S. Kuhn con riguardo al progresso scientifico. Secondo Kuhn, in una data epoca, la maggior parte degli scienziati svolgerebbe la propria attività all’interno di una scienza definita “normale”, dagli orizzonti cioè ben confinati all’interno di una certa tradizione, definita appunto “paradigma”, tracciata e delimitata dalle scoperte scientifiche compiute nelle epoche precedenti. Tuttavia, anche grazie al lavoro di questi scienziati “normali”, questa tradizione viene costantemente sottoposta a critica, e di conseguenza erosa nelle sue certezze, spesso tramite l’esperienza diretta dei suoi limiti. Fino a quando la consapevolezza della sua insufficienza diviene palese e generale. Da questa consapevolezza nascerebbero le “rivoluzioni scientifiche”, i nuovi approcci al problema, grazie alle quali si giungerebbe a porre un nuovo paradigma e il ciclo ricomincerebbe. Applicando il modello di Kuhn allo studio della Storia, ci si accorge in altre parole di tutti i limiti del pensiero di Fukuyama, dato che esso poggia su un paradigma univoco che non viene contestato, essendo piuttosto assunto come postulato del ragionamento. La critica di Fukuyama, in altre parole, si arresta di fronte all’impalcatura sociale e culturale delle moderne società occidentali. Ritiene “geometricamente” fondate proprio quelle strutture – sociali e culturali – che viceversa dovrebbero essere più correttamente considerate frutti della Storia e dell’evoluzione sociale. E, così facendo, diviene dogmatica e antistorica.
A.S. (3 Marzo 2017). Viviamo un epoca nella quale neanche le scienze fondamentali sembrano aver trovato i loro paradigmi definitivi, posto che la ricerca scientifica e le nuove conquiste li rimettono in discussione e ne decretano la morte. Nel campo sociologico, a maggior ragione è facile evocare delle novità concettuali e nuovi paradigmi, come cornice di risposte non ultimative e di per se instabili, collegabili a spazi di valutazione come quello che attiene l’immaginario collettivo ed i comportamenti sociali, cioè la fattualità generata. La domanda se ci si trova di fronte ad un nuovo paradigma comporta una risposta che chiarisca se ci si trova di fronte ad una presa d’atto di un nuovo e significativo cambiamento ,sia concettuale che fattuale e se i paradigmi , che fino a quel momento erano stati la cornice della vita sociale e politica, siano da considerare morti e sepolti.
Fi.I. (3 Marzo 2017). Gli indizi che abbiamo sembrano condurre a una risposta affermativa all’interrogativo da Lei posto. La nostra società sta subendo dei repentini cambiamenti: globalizzazione, migrazioni di massa e innovazioni tecnologiche stanno trasformando in misura molto rilevante l’aspetto della nostra quotidianità. Ci troviamo di fronte problemi che le generazioni precedenti, comprese le più vicine alla nostra, non hanno dovuto affrontare: dalla gestione del multiculturalismo sociale a quella della crisi ambientale che sta dissestando l’equilibrio ecologico del Pianeta. Sta sorgendo, nell’intellighenzia mondiale come nella pubblica opinione, una nuova consapevolezza dei processi che regolano la nostra convivenza fra uomini e quella con l’intero ecosistema di cui siamo parte. Ciò conduce, mi sembra, a dover elaborare nuove forme di gestione delle risorse, nuovi modelli di società, nuovi paradigmi etici. Ho l’impressione, in altre parole, che la Storia sia tutt’altro che finita.
C.D.L. (4 marzo 2017). Penso che a Fukuyama sia rimproverato una specie di millenarismo laico legato ad una concezione “straussiana” (la storia come progressiva affermazione del liberalismo). Ma forse questo non era nell’intenzione dell’autore che, occorre ricordare, elabora una teoria da utilizzare nell’immediato. È questa la funzione dei think-tank americani da cui Fukuyama proviene. Produrre analisi politiche, non storiche. La prospettiva di Fukuyama è di breve medio-termine.
ÉLITES E OLIGARCHIE IN DEMOCRAZIA (1 Novembre 2016)
MS (1 Novembre 2016). Ottima analisi, Carlo, da cui secondo me emergono due punti critici, che meriterebbero ulteriori approfondimenti: 1. come sviluppare, regolare e garantire i meccanimi di relazione fra la democrazia partecipata e la sua espressione “verticale” di democrazia rappresentativa? Ovvero, come favorire e rendere “cogente” quella circolazione delle idee, della cultura, degli strumenti di analisi del reale, che rendono poi il momento della rappresentatività non più un mero momento di delega “cieca” inevitabilmente basata su un’identificazione fideistica che costituisce poi la base per il meccanismo oligarchico inteso nella sua peggiore accezione? 2. La natura transnazionale e globale dei meccanismi di potere è ormai evidente a tutti, come evidente a me pare la loro spersonalizzazione: non più individui o classi sociali identificabili che si contrappongono per il predominio, secondo i superati (sotto questo aspetto) precetti marxiani, ma il nebuloso aggregato di “stakeholders” nell’interesse dei quali si muove come un serpente acefalo la finanza mondiale. Regolare e mitigare questi interessi spersonalizzati (non volendo accettare la teoria del TINA e ritenendo, con Voltaire, che questo non è il migliore dei mondi possibili) presume la capacità di trascendere il livello nazionale e sviluppare meccanismi di rappresentanza e di controllo a livello globale; e in questo concordo con la tua asserzione della necessità di dare impulso alla EU: resta però da capire come evitare che questo processo sia governato dalle stesse impersonali eleite fnanziarie che si vorrebbero contrastare e come sviluppare un terredo di confronto “dal basso” che sia in grado di individuare e definire il terreno degli interessi comuni e le pratiche per “coltivarlo” superando le contrapposizioni di carattere nazionalistico. Intendo dire che, in assenza di una capacità di creare una comune identità sovranazionale (e a me pare che sotto questo aspetto siamo piuttosto indietro) diventa quasi inevitabile il prevalere dell’interesse opposto, che mi pare anche diffcile definire oligarchico … direi piuttosto multiforme, spersonalizzato, disumanizzato. In sintesi, in assenza di una rappresentanza degli interessi della stragrande maggioranza delle persone, il vero rischio, secondo me, non è il governo di una oligarchia, ma peggio, che questa oligarchia operi in nome e per conto di un soggetto spersonalizzato e non identificabile, come nel peggiore degli incubi letterari di Philip K. Dick.
FI (1 Novembre 2016). Complimenti Carlo, l’ho letto con grande piacere. Così come ho letto con piacere le considerazioni di Nadia Urbinati, che mi erano sfuggite. Rimango della mia opinione, cioè che in buona sostanza abbia ragione Scalfari e torto Zagrebelsky: la democrazia rappresentativa altro non è che una forma di oligarchia, anche se è l’unica democrazia possibile (quest’ultima considerazione è mia, non ritengo la democrazia diretta autenticamente democratica, negli intenti e negli esiti). Ciononostante, debbo dire che le parole della Urbinati, il suo riesumare quei “corpi intermedi” tanto cari ai nostri costituenti (e non solo a loro), mi hanno fatto l’effetto di una boccata d’aria fresca. Perché probabilmente proprio in questo sta la differenza tra una democrazia (per quanto oligarchica) e un’oligarchia non democratica, nella presenza cioè di una pubblica opinione vitale, fresca, attenta e accorta e non di un mero “corpo elettorale” asfittico, annoiato e disinformato. E’ un po’ l’altro lato della medaglia di quel concetto di accountability sul quale tanto spesso ti sei soffermato nei tuoi scritti. Di certo, un peso non indifferente nella progressiva involuzione che l’elettorato ha subìto negli ultimi anni (o decenni, sarebbe meglio dire) ce l’ha anche la globalizzazione, cui accenni sul finire dell’articolo e a cui si deve l’estromissione della politica da molte decisioni, rimesse ormai ad attori ad essa estranei e mossi da interessi economici difficilmente governabili attraverso strutture istituzionali come quelle attuali. Ma rimango dell’idea che una pubblica opinione davvero libera e forte riuscirebbe comunque a predisporre argini resistenti al dilagare degli interessi economici delle oligarchie industriali e finanziarie, saprebbe stigmatizzarne le furberie e gli approfittamenti e indovinare, nel momento stesso del loro farsi, quei provvedimenti legislativi più smaccatamente funzionali alla tutela di interessi privati e non comuni, così da impedirne l’emanazione o tamponarne gli effetti più rovinosi. E invece questa pubblica opinione non riesce più a formarsi, langue in un sonno sempre meno disturbato dal continuo cicalare di opinionisti, intellettuali (veri o presunti), demagoghi e (sedicenti) demiurghi d’ogni sorta. E così si consolidano le oligarchie (non solo politiche ma corporative), e dei nostri destini comuni siamo sempre meno indotti a interessarci, mentre siamo confinati a un ruolo da spettatori di una commedia che non di rado assume i toni della farsa, se non della tragedia. Con buona pace della rappresentatività.
LT (2 Novembre 2016). Non c’è che dire, post estremamente interessante e stimolante. Resta ancora irrisolto e oggetto di riflessione ed osservazione il tema di fondo dei nostri tempi: la globalizzazione ha di fatto creato dei nuovi poteri sovranazionali essenzialmente economico-finanziari e mediatici. In Europa nel 700 la rivoluzione francese diede inizio agli stati nazione moderni e al modo di gestirli, dittatura e/o democrazia. Nel XXI secolo siamo consapevoli che la globalizzazione sta determinando una nuova fase di risposte alle necessità della globalizzazione. Non demonizzo i nuovi poteri sovranazionali economico-finanziari, constato solo che sono la risposta molto parziale alla nuova fase dell’evoluzione sociale è un divenire con molte incognite. Per quanto attiene a Scalfari, pur apprezzando il suo pensiero, lo trovo limitato dal passato della sua formazione ed insoddisfacente nel prefigurare scenari del futuro. Mentre trovo assai interessante quanto la chiesa cattolica, con l’attuale papa sta facendo in quello che chiama dialogo ecumenico, ma che racchiude la necessità e la comprensione della riunione dei cristiani per far fronte agli interrogativi della globalizzazione. Devo riconoscere da ateo qual sono, che la risposta più densa di soluzioni alla globalizzazione è attualmente quella della chiesa.
SECOLARIZZAZIONE, ISLAM, OCCIDENTE: BREVI RIFLESSIONI (1 Ottobre 2016)MS (2 Settembre 2016). Molto, molto interessante. Una serie di spunti di riflessione sul rapporto della natura umana col trascendente e di come questo rapporto, e la sua sistematizzazione, condizioni e venga a sua volta condizionato dalla struttura sociale. Interessante l’analisi dei rischi che un’etica non condivisa, civile o religiosa, può comportare per i principi basilari della libertà. E soprattutto interessante l’analisi dell’impatto che il neoliberismo comporta sull’accettazione o il rifiuto di un principio di responsabilità etica che poi è alla base di ogni struttura sociale. E sotto questo profilo credo importante valutare le caratteristiche e gli elementi di “socialismo” che molti regimi confessionali islamici portano con sè; non voglio con questo dire che ci siano concreti e pervasivi elementi di vero socialismo in questi regimi, ma senza dubbio una gestione diversa del sistema finanziario, un’attenzione più marcata alla mutua assistenza, un “dovere” di solidarietà sociale imposto dalla stessa dottrina religiosa, forniscono ai regimi islamici elementi di attrazione nei confronti delle classi disagiate che sono innegabili, e che forniscono anche una base concreta di propaganda anti-occidentale. Non si può trascurare, infatti, il consenso che hanno organizzazioni come Hamas o anche lo stesso Daesh fra molte persone che non sarebbero fondamentaliste di per sè, ma che abbracciano l’ideologia teocratica proprio sulla base di una dichiarata “equità sociale”, pur basata sul rispetto di ferree regole religiose, che si oppone nettamente al modello di mercato de-responsabilizzato che prevale in occidente e che genera una evidente frattura fra le classi privilegiate sempre più ristrette e potenti e quelle disagiate, sempre più ampie, marginalizzate e ridotte in miseria. Temo che, fino a che la struttura sociale e economica dello stato laico, inteso come libera organizzazione delle persone tesa a perseguire progresso e benessere, continuerà a mostrare gli evidentissimi problemi che stiamo riscontrando a livello globale, i fondamentalismi religiosi continueranno a prevalere, trasformando il rapporto col trascendente in una questione di natura economica e sociale, laddove invece dovrebbe, nel terzo millennio, evolversi in una questione essenzialmente individuale, che regola e indirizza i comportamenti soggettivi, ma non condiziona la struttura e le dinamiche dei rapporti sociali. Di fatto, il fondamentalismo religioso attecchisce dove i modelli etico-sociali di impronta laica non riescono a proporre una alternativa concreta e praticata andando, con tutte le sue tragiche storture, a riempire il vuoto di giustizia e di solidarietà che il modello neoliberista lascia in modo fin troppo evidente.
CDL (2 Settembre 2016). Trovo molto interessante il collegamento tra la capacità di attrazione dei movimenti islamici ed il loro coinvolgimento nei problemi sociali. Un argomento che hai ben sviluppato e che nel mio testo non era trattato. Grazie.
AP (9 Settembre 2016). Mi permetto di rilevare che non c’è nessuna necessità logica fra i dati della House of Freedom ed il processo di secolarizzazione. Più probabile il combinato disposto di altri fattori:
Il collasso dell’equazione Liberale secondo la quale il “benessere” è il prodotto della libertà individuale. Così almeno nell’esperienza economica recente di Russia, India e Cina solo per citarne alcuni.
1. Il collasso dell’equazione Liberale secondo la quale il “benessere” è il prodotto della libertà individuale. Così almeno nell’esperienza economica recente di Russia, India e Cina solo per citarne alcuni.
2. Il venir meno dell’antagonismo “marxista” alla metafisica capitalista. Così, ad esempio, l’esperienza del fu Comandante Marcos o della questione Palestinese, tanto per citare pochi casi.
3. L’evoluzione del sistema di produzione capitalistico che, di recente, pretende di generare denaro senza l’intervento dell’incarnazione nell’opera dell’uomo. Per dirla in breve, se Marx poteva permettersi di scrivere D-M-D’, oggi il capitalismo è riassumibile in D-D’ con buona pace dell’emancipazione attraverso il lavoro. Naturalmente lo stesso vale per la dialettica padrone-servo di Hegel e, più in generale, di qualunque aspirazione umana che passi per l’azione (Heidegger).
4. La fede religiosa e le istituzioni ad essa collegate sono, da sempre, degli ottimi contenitori di “follia”. Follia in netto avanzamento globale per via dell’iperstimolazione del desiderio: asse portante del consumismo. Non a caso, la sindrome più diffusa in occidente (e solo perché dei pretesi terapeuti hanno arbitrariamente deciso di “curarla”) è il disturbo dissociativo bipolare: segno di ego rarefatti che hanno perso le pareti (“santo” quanto, mi permetto, “ragione”) per il proprio “sacro”.
A questo aggiungo, e sottoscrivo per quel che vale, “una globalizzazione dominata da gruppi finanziari irresponsabili”. Ma la questione è altra: che fare?
CDL (9 Settembre 2016). Non mi convincono gli approcci troppo economicistici. I fattori economici, e tra questi la globalizzazione finanziaria “irresponsabile”, hanno certamente rilevanza ma non sono esaustivi. Nella dinamica della storia intervengono ulteriori fattori, di natura culturale, che pure agiscono con meccanismi potenti ed efficienti. Il testo discute questi aspetti e forse pecca di presunzione proprio perché si ripropone di esplorare fattori culturali operanti ma difficilmente intellegibili.
LA DEMOCRAZIA ILLIBERALE (1 Dicembre 2015)
GIL (6 Luglio 2016). Leggo sempre con interesse e piacere gli scritti del blog. Persiste – a mio parere – l’usuale limite di fondo di una chiave di lettura interna alla provenienza dal democraticismo: che tende ad esaltare questo, anche con appropriazione di quanto invece più proprio al liberalismo; col risultato di restringere ed impoverire quest’ultimo, deformandolo in una visione decentrata e border-line; che tende a proiettare ed enfatizzare sempre ed oltremodo la divisione/distinzione – già esistita – tra movimento democratico e movimento liberale, a dispetto del fatto che oggi (e da tempo) è sostanzialmente riassorbita nel più fervido mix politico contemporaneo che è il movimento e le politiche liberaldemocratiche (forse tu le indicheresti quali democratico-liberali); che tende ad assegnare a tale liberalismo “ridotto” al solo filone classico e “negativo” (quello delle libertà negative”) il “richiamo della foresta” del liberismo ed al termine democrazia la continuità liberaldemocratico. Ma se si supera questa particolare chiave di lettura (frutto della tua passione ed internalità al movimento democratico che ha il mio pieno rispetto, stima, ma anche “comprensione” nel duplice significato del termine) a mio parere ingenerosa verso il liberalismo, si apprezza il tutto grandemente. Ti chiedo scusa ma vorrei solo obiettare che il liberismo è tendenzialmente una forma di democrazia economica – più di quanto sia una forma di liberalismo economico. Il mercato delle idee e delle azioni ed il mercato dei beni dove ogni attore partecipa ed esprime la sua interazione con gli altri: le une e le altre forme di mercato (di partecipazione democratica) sublimate e superate dal costituzionalismo (tipica espressione del liberalismo) che pone limiti indefettibili a ciò che si può esprimere pur a maggioranza; il costituzionalismo che supera anche il primato della legge e della volontà democratica che esprime la legge, sottraendo ad essa alcuni valori non negoziabili, neanche democraticamente, oltre che autoritariamente. Ma anche io rischio di massimizzare i distinguo, ben oltre il dovuto e il necessario, svilendo la grandezza insuperata ed unitaria della liberaldemocrazia e dell’essere liberaldemocratico; cioè la integrata ed ormai indistinguibile grandezza di liberali e di democratici contemporanei, con i loro filoni più timidi e moderati ed i loro filoni più audaci e radicali; con le loro tendenze più sociali e le loro tendenze più individualisticheggianti ed elitarie; con le loro filiazioni dirette quali il femminismo, l’ambientalismo non luddista e non anti-moderno; il “piratiamo” con le sue aspirazioni spesso estremizzate di liberalismo e democrazia nel settore della conoscenza e della informazione; con la loro enorme ricchezza interna e capacità di riflessione, speculazione e discussione introspettiva. Una caratteristica quest’ultima ed un arredo politico-culturale che non ha pari nel confronto con le altre famiglie di idee. Sia rispetto a quelle dei cugini del socialismo post-illuminista (dalla grigia socialdemocrazia alla vogliosa grandeur socialista che ancora però scopiazza politiche e valori del mondo liberaldemocratico limitandosi a infiocchettarli di suo, dalla utopia comunista tanto solar-avveniristica, quanto bugiarda, al parossismo di questa che ripudia ogni valore liberaldemocratico e rinnega la sua stessa genesi culturale). Sia rispetto agli eterogenei – ma politicamente unidirezionali- “altri”, la famiglia dei conservatori e tradizionalisti (moderati o decisi) che convivono con pienezza nella architettura della democrazia liberale di cui pure non sono artefici, né (talvolta) grandi estimatori. Sia infine rispetto agli avversari di sempre; gli ultra-conservatori ribelli alla struttura istituzionale liberaldemocratico, i reazionari di varia filiazione che si ripresentano nei vari aspetti del controrivoluzionarismo in poi: localisti (che si mistificano per federalisti ma rimangono espressioni della cultura di “moglie e buoi dei paesi tuoi”); nazionalisti di ritorno (filoni ritardati e irrazionalmente nostalgici di un movimento che, oltre un secolo fa, fu progressista e fu vicino a liberali e democratici); fondamentalisti che si esprimono pervasivamente e mondanamente con la “scusa del divino” e dei suoi interpreti (autorizzati o meno, conformisti od eretici che siano). Quanto basta per dare il giusto enorme valore alla discussione culturale sia storica che in chiave di attualità, ma senza perdere di vista il punto focale che le varie tendenze liberali, democratiche e liberaldemocratiche sono “correnti” rigorosamente interne a quel partito (che, almeno con riferimento all’Italia, gli amici di “Critica liberale” indicherebbero per “il partito che non c’è ancora”) fondato sull’Umanesimo, sul Cittadino (il singolo individuo), sulla Cittadinanza (la comunità di riferimento, di espressione e di interazione del singolo), che è la politica che realmente e definitivamente ci appassiona e che merita la nostra superiore attenzione.
CDL (6 Luglio 2016). Ti ringrazio per l’apprezzamento ed anche per la critica, colta ed articolata. Sono sinceramente onorato della tua attenzione. Come hai correttamente osservato le mie idee vengono dalla tradizione democratica ma io mi considero un vero liberaldemocratico. Sono infatti convinto che, come sosteneva Bobbio, da tempo liberalismo e democrazia siano ormai inscindibili e obbligati a contemperarsi, l’uno privilegiando il concetto di libertà individuale, l’altra quello dell’eguaglianza. Un’unica famiglia che, come hai rilevato, rimane distinta sia dal socialismo che dal conservatorismo. Questa cultura ha avuto radici diverse ma si è evoluto in maniera convergente ed anzi sostanzialmente unitaria. Dando vita alla civiltà occidentale, a quella che infatti chiamiamo democrazia liberale, risultata così includente da accogliere ed integrare anche la questione dei diritti sociali. Al di là della spinta delle socialdemocrazie europee, non si dimentichi che il Welfare è un’invenzione della cultura liberaldemocratica. Così ad esempio il sistema sanitario universalistico fu introdotto in Gran Bretagna da un governo liberale. E’ però convinzione di molti (me compreso) che oggi le democrazie liberali stiano subendo una profonda ristrutturazione ad opera di una cultura, appunto il conservatorismo, che in ambito economico ha assunto le sembianze della deregulation di Reagan e della Tatcher. La principale conseguenza di quella politica è stata una globalizzazione dominata dai gruppi economici finanziari che sulla base di interessi comuni si muovono coerentemente l’uno rispetto all’altro ed agiscono su scala mondiale. Al contrario i governi hanno interessi spesso divergenti e si muovono su scala locale o al massimo (gli USA) sovraregionale. La pressione (in certi casi i ricatti) delle lobbies economico-finanziarie sui governi rischia di rimettere in discussione conquiste che sembravano ormai acquisite almeno nelle democrazie liberali di vecchia data.
L’UGUAGLIANZA NELLA TRADIZIONE DEMOCRATICA: APPUNTI SPARSIFI (2 Giugno 2016). Mi pare veramente sottile il filo che unisce la filosofia politica di Rousseau a quella di Rawls. Infatti anche se lo stesso Rawls considerava la sua opera come un tentativo di aggiornare e approfondire l’idea del contratto tracciata da Locke, Rousseau e Kant mi sembra che sia andato parecchio oltre, perlomeno rispetto a Rousseau. Ho sempre visto nella volonté générale di R. un trucco, un espediente, una sorta di fictio juris ideata per conciliare l’inconciliabile cioè la libertà individuale e la necessità della dimensione sociale e politica che costringe l’uomo, per sopravvivere, ad associarsi ad altri uomini e a costituire le comunità. Rousseau inventa questa cessione delle libertà e dei diritti che ogni individuo, col patto originario, versa nel calderone sociale. In questo modo ognuno dei contraenti perde la sua qualità di individuo e guadagna in cambio quella di membro della comunità. è questo secondo me il passaggio rilevante: in realtà è lo stesso Rousseau ad ammettere che con l’ingresso in comunità l’uomo perde le sue libertà di individuo. Una volta uscito dal crogiolo il cittadino di Rousseau è solo una voce nel coro, che non è polifonico ma esprime una sola volontà, quella generale. Rousseau annulla in realtà la dimensione liberale dell’uomo politico, perché intende la libertà solo nello stato ideale di natura, nella condizione ferina dell’homo homini lupus, che è insostenibile e va superata. Rawls in realtà è a mio avviso molto più consapevole che la libertà è in realtà un valore schiettamente politico ed è una reazione artificiale alla lotteria naturale. Mi sembra che Rawls la veda come una potenzialità dell’uomo o, forse meglio, come il bene sociale che è necessario coltivare perché gli uomini esprimano le loro potenzialità individuali. La sua è una prospettiva meno collettivista, molto più liberale. La società equa è necessaria all’emersione dell’uomo. Considera ad esempio uno dei principi base della Teoria della Giustizia, quello di differenza, secondo il quale le ineguaglianze economiche e sociali nella distribuzione dei beni primari devono essere ammesse solo se vanno a migliorare la condizione dei più svantaggiati. E’ una elaborazione più radicale del nostro bellissimo articolo 3, comma 2 Cost ed esprime un principio che è parecchio lontano da Rousseau, ossia il fatto che è la società che è al servizio dell’uomo e non viceversa.
IL RADICALISMO DI SINISTRA ED IL RISCHIO POPULISTA
FI (8 Febbraio 2015). Molto interessante. C’è da augurarsi che l’emergenza dei populismi costringa le i sistemi liberaldemocratici a diventare più democratici e più liberali. Credo d’altra parte che sia una tendenza storica già avviata sotto molteplici aspetti. In settimana, ad esempio, ho assistito a una lezione di diritto civile nella quale si sono analizzate le influenze della legislazione europea sull’elemento causale dei negozi giuridici, che stanno conducendo a una generale rivisitazione del concetto di autonomia privata, da intendersi non più solamente in senso formale (cioè fondata sul dogma della formale parità tra le parti del contratto) ma sostanziale (cioè calibrata sulla sostanziale parità/disparità informativa e/o economica dei contraenti). Questa attenzione al reale equilibrio degli accordi comporta il trasferimento del “fuoco” del sindacato giurisdizionale dalla libertà alla giustizia, attraverso l’interpretazione della prima (art. 41 Cost. libertà di iniziativa economica) alla luce del principio generale di solidarietà (art. 2 Cost.). Ovviamente questa linea interventista comporta seri rischi: uno tra tutti quello che il giudice diventi una terza parte del contratto, ovvero quello dell’incertezza dei rapporti giuridici che deriverebbe da imprevisti interventi ortopedici sugli assetti contrattuali da parte dello stesso. Sta di fatto che la rinnovata attenzione alla libertà intesa in senso sostanziale e non più acriticamente formale si impone per evitare abusi di potere, che si manifestano a tutti i livelli come esiti di vecchie concezioni di laissez faire. Al di là dell’esempio, credo che lo stesso fenomeno e le stesse esigenze si manifestino nella politica, interna e internazionale, nel senso che l’equità delle relazioni internazionali debba passare necessariamente per un sostanziale “inspessimento” procedurale delle fonti degli accordi, ossia, politicamente, nella reale democratizzazione delle istituzioni che governano e stabiliscono quegli accordi. Questo mi porta a pensare che per arginare il pericolosissimo fenomeno dei populismi, nei quali un pincopallino qualunque si fa interprete di una granitica volontà generale (che, in quanto granitica, tanto generale in fondo neanche è), occorre alla svelta avviare un processo di reale legittimazione democratica dei corpi rappresentativi a livello europeo. Questo mi sembra il primo passo, che probabilmente ne porterebbe altre centinaia.
CDL (8 Febbraio 2015). Alcuni autori americani, Macey e Miller, a proposito della tesi di Fukuyama sulla fine della storia, scrivevano già nel 1992: “Egli non sa riconoscere che ci sono diverse concezioni di liberalismo e di democrazia e che saranno queste differenze a determinare verosimilmente le battaglie ideologiche del futuro”. In particolare questi autori ritenevano che Fukuyama non riuscisse ad apprezzare la tensione tra liberalismo e democrazia e concludevano osservando che le democrazie potevano essere divise in “inclusive” ed “escludenti” sulla base della capacità o meno di rappresentare le esigenze anche immateriali dell’intera popolazione.
FI (8 Febbraio 2015). Molto d’accordo con loro. Dopo aver letto Fukuyama ho pensato che la sua tesi fosse o ovvia o sbagliata. Ovvia se intesa a dimostrare il definitivo superamento delle autocrazie del 900; sbagliata se volta ad affermare la definitiva vittoria della liberal democrazia americana. La storia è tutt’altro che finita. Ci sono segnali che molte dinamiche politiche e economiche ch si sono affermate negli ultimi 30 anni stiano segnando il passo. Credo per esempio che il neoliberismo reaganiano sia un modello storico al quale non si potrà tornare; credo poi che la questione ambientale, messa un po’ in secondo piano con la crisi, avrà un effetto decisivo e imprevedibile sui connotati del capitalismo del XXI secolo, sia per quanto riguarda le tecniche di produzione sia con riguardo alla questione della distribuzione delle risorse.
IGINO GIORDANI, LA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849 E LA MODERNITA’ CATTOLICAMC (1 Aprile 2014). Giordani: già Partito Popolare, nel Ventennio direttore della Biblioteca Apostolica Vaticana. Quanto riporti non coincide con quanto sosteneva Leone XIII nella Rerum Novarum, sull’inevitabilità dell’iniquità di questo mondo come conseguenza del peccato originale: del resto la storia delle democrazie cristiane è una storia democraticamente valida, anche se discutibile o esecrabile per altri versi. Del resto andrebbero approfondite le consonanze fra pensiero sociale cattolico (più che dottrina sociale della Chiesa, almeno fino al Concilio e poi con Wojtyla e Ratzinger) e pensiero diciamo così mazziniano: sul piano operativo hanno più somiglianze fra loro che col liberalismo e il marxismo; e sono uniti anche su questo spirito di fraternità fra le classi – né guerra né “feconda dialettica”, ma fusione
CDL (1 Aprile 2014). Penso che I. Giordani esprimesse una sensibilità intellettuale ed un’apertura mentale non comuni e certo non diffusi nel mondo cattolico. Con questa corrente di pensiero il mazzianesimo ha delle affinità. In particolare sul piano della centralità dell’Uomo e della sua relazione con l’altro. Penso anche che le riflessioni di Giordani siano minoritarie nel mondo cattolico che preferisce risolvere la questione della relazione con l’altro attraverso la carità (quando va bene) piuttosto che attraverso il riconoscimento dei diritti altrui.
MC (1 Aprile 2014). Esattamente, per Leone il male è ineliminabile ma la carità e la solidarietà lo alleviano, anche a salute dell’anima e “ad socialismi pestem evertendam”.
IN EUROPA UNO SCONTRO DI CIVILTA’SC (3 Maggio 2014). Le “ricette” Reagan e Thatcher non sono mai state applicate né in Spagna, né in Portogallo, né in Germania e tantomeno in Italia. I partiti popolari (cattolici) hanno sempre applicato ricette “social democratiche”, mantenendo un’economia fortemente statale, quando le “ricette liberiste” vogliono ZERO aziende statali, sanità privata, scuola privata … alcuni ipotizzano anche la difesa privata. Pertanto di liberismo in Europa ne esiste poco, pochissimo. Non è certo una mia ambizione che venga applicato in Italia, però è giusto evidenziare che liberisti in Italia non lo siamo da prima della prima Guerra mondiale. Considerando che la spesa pubblica in Italia è aumentata moltissimo negli ultimi 20 anni ritengo sia impossibile parlare di ricette liberiste, considerando che il livello di tassazione per sostenere la spesa ha raggiunto per le aziende il 70% credo sia impossibile parlare di ricette liberiste. I concetti liberisti sono altri, spesa azzerata o quasi, tasse al minimo, chi non ha si arrangi, cercherà di sopravvivere e pertanto adeguerà le sue richieste fino a trovar qualcosa da fare che gli permetterà di sopravvivere. In Italia ricette liberiste non sono mai state applicate se non in campo finanziario, lasciando quasi pieno controllo al mercato, con tassazione bassa, i risultati sono evidenti ma la finanza è spesso gioco statistico e pertanto un’azzardo. Le ricette di cambiamento del mercato del lavoro sono una piccola parte, piccolissima del pensiero liberista, ma non certo la flessibilità. I liberisti credono nel libero mercato del lavoro, segue nella totale libertà di licenziare. Anche qui un po di flessibilità è lontana dalle ricette liberiste. La flessibilità è necessaria per adeguarsi ad un mercato che ha una velocità di cambiamento cento volte superiore a quello che esisteva 30 anni fa. 30 anni fa un modello di automobile aveva un ciclo di vita di 10 anni, oggi 3, 4 … prima esistevano 4 modelli per ogni casa automobilistica, ora 15, 20. Le esigenze dei consumatori sono cambiate, la concorrenza è cambiata, il mondo è diverso, o ci si adegua al cambiamento o si fa come accadde alla Roma Imperiale nell’800, alla Cina nel 1500, e a tutti i “mondi” che vissero la loro epopea ma non vollero adeguarsi al nuovo che avanzava. Il nuovo schiaccia il vecchio, sia che lui voglia, sia che mon voglia, è la teoria di Darwin della sopravvivenza.
CDL (4 Maggio 2014). Una definizione, credo condivisibile, di liberismo fa riferimento ad una concezione dell’economia nella quale è centrale il libero mercato e l’intervento dello Stato è ridotto al minimo. Siccome una politica liberista “pura” non è mai stata applicata, almeno in occidente, più difficile è stabilire i criteri sui quali misurarne il livello. La spesa pubblica è certamente un criterio ma con Reagan il debito pubblico americano ebbe una crescita rilevante. Il livello di imposizione fiscale è un altro criterio e con Reagan diminuì (e fu una della cause della crescita del debito pubblico). L’ampiezza dello stato sociale è un ulteriore criterio e con Reagan non diminuì ma neanche si ampliò. Le condizioni di libero mercato sono un ultimo criterio e Reagan le facilitò. Che cosa è successo in Europa? Ovviamente cose molto diverse. La spesa pubblica è diminuita in alcuni Paesi ed è cresciuta in altri; la tassazione è diminuita in alcuni Paesi ed è aumentata in altri; lo stato sociale si è contratto un po’ ovunque, Italia compresa sia in tema di diritti (o privilegi) del lavoro sia nell’ambito della sanità. Per questo ho sostenuto che il vento liberista ha influito su tutto l’occidente. E oggi questo vento è ancora efficiente perché la politica di riduzione del debito pubblico, che è l’aspetto centrale dell’austerità, implica un ulteriore contrazione dello stato sociale. Da vecchio lamalfiano non posso non condividere una politica di riduzione della spesa pubblica ma sostengo che oggi, in una congiuntura economica recessiva, tale politica deve essere perseguita con prudenza. Rimane altresì necessaria per l’Italia (non per altri Paesi). Nella discussione non ho sinora utilizzato l’ultimo criterio liberista, quello relativo alle regole della libera concorrenza, perché è un problema che riguarda principalmente l’Italia. Un Paese, il nostro, che ha avuto un processo di industrializzazione rapido costruito su due elementi: il monopolio pubblico e, in misura minore, privato nell’ambito della grande impresa; l’evasione fiscale consentita e incentivata per lunghi anni nell’ambito della piccola impresa. In sostanza lo Stato ha finanziato sia la grande impresa che la piccola impresa. Se questo poteva avere un senso nell’immediato dopoguerra (si trattava di costruire un tessuto industriale e “proteggerlo”) è diventato sempre meno comprensibile nel corso del tempo. Per quanto riguarda gli oligo-monopoli, essi sono diventati quasi tutti privati con un processo poco o niente affidato al mercato e guidato da una classe politica che ha badato a favorire e costruire gruppi industriali “amici”. Con un peggioramento netto dell’efficienza che non dipende dalla natura della proprietà ma dalle condizioni di libero mercato. Quando ci siamo dovuti aprire al mondo la grossa impresa è stata spazzata via o comprata pezzo a pezzo da capitali stranieri; la piccola impresa, che inopinatamente pretendeva di inseguire la Cina sul costo del lavoro, ha mostrato tutta la sua inadeguatezza. Oggi se il governo volesse fare una riforma a costo zero con risultati probabilmente a breve termine, sarebbe proprio quella di spazzare via tutte le posizioni dominanti che ancora governano il mercato in Italia.
SC (4 Maggio 2014). Condivido appieno questa tua ultima “fotografia”. In Italia come hai detto tu si è creata un’economia principalmente pubblica o privata nei primi anni libera, poi sempre più assistita. Questa situazione non è poi molto diversa dall’economia “socialista”. Ora è evidente che per passare da questo modello economico, fallimentare in condizioni di libero mercato, fallimentare anche in economie protette sul lungo periodo (come hanno dimostrato i paesi comunisti), ad un modello economico differente serve: Regole certe, Grandi capitali, Grandi investimenti in ricerca, Cultura diversa. Per me è evidente che questi requisiti non ci sono in Italia … I capitali privati sono esigui poiché si ci è concentrati su un’economia statale. Pertanto impossibile fare grandi investimenti in ricerca. La cultura italiana è del posto fisso a vita (senza aggiornamenti), la cultura italiana è dei soldi facili ottenuti per conoscenze, amicizie, non quella dei grandi progetti. Le regole aimhe le fanno coloro che hanno questa cultura. Che fare allora? Siamo destinati al fallimento? Per me no ed è proprio l’Europa la più facile via di salvezza. In Europa ci sono i capitali, altre aziende sono abituate ad investimenti pluriennali, in Europa la cultura è diversa da quella Italiana e può essere vincente, in Europa le regole ci sono e vengono rispettate. Ecco perché è l’Europa, sentirsi Europei e non più Italiani la nostra via di salvezza, un poco più “Social liberali” o “Repubblicani” se preferisci e molto meno “Socialisti”. Stiamo dicendo cose simili, fotografiamo l’esistente nello stesso modo.
MATTEO RENZI CHI?MC (15 Marzo 2014). Bellissimo approfondimento … Ho sottolineato in particolare due osservazioni nel tuo testo a cui ho aggiunto delle mie considerazioni che nmi avete già sentito fare , ma che mi sembra si colleghino molto bene alla tua riflessione . L’ attenzione sugli ultimi e non sul tema della “libertà dalla soggezione (diremmo come repubblicani) per tutti i cittadini . D’altra parte sono decenni che l’attenzione per gli ultimi viene utilizzata come alibi per l’ attacco ai diritti dei penultimi , sono decenni che viene promosso una guerra fra poveri e poverissimi a tutto beneficio degli Happy fews che vedono in continuazione rafforzare la propria ricchezza . Il ceto medio che nella retorica dei liberali doverebbe essere il fulcro della società sta restringendosi e proletarizzandosi in tutto l’ occidente , senza che gli ultimi ne traggano alcun beneficio. In quest’ ottica deve essere anche vista la retorica del cambiamento dato per positivo a prescindere dalla direzione verso cui si cambia . All’ esempio del cambiamento di Reagan e Thatcher riportato nell’ articolo possiamo portare quello ancora più chiaro di ciò che sta accadendo dall’ altro aprte del mediterraneo : gli innovatori sono quelli che vogliono la sharia, la disuguaglianza fra i sessi , la punizione della apostasia , i conservatori sono coloro che vogliono preservare i valori dello stato laico . Siamo certi che da noi la situazione è così diversa ?
PP (15 Marzo 2014). Se non ricordo male vi era nella Firenze dell’immediato dopoguerra un movimento che si chiamava per l’appunto “gli ultimi” o qualcosa di simile, ed in esso confluivano cattolici di varia provenienza non esclusa quella fascista.
UGO LA MALFA SUL FRONTE AMERICANO DELLA SOLIDARIETA’ NAZIONALEMC. Cari amici ad integrazione del bellissimo documento che avete pubblicato sull’ articolo di Ugo La Malfa sul PCI, pubblicato da Foreign Affair vi vorrei proporre qualche riflessione e i link ai grandi dibattiti del 65 66 di La Malfa con Ingrao, Amendola, Foa , una grande riflessione su quello che si chiamava il modello di sviluppo , e il fallimento della ricerca dell’ ora X, una lezione anche per oggi.